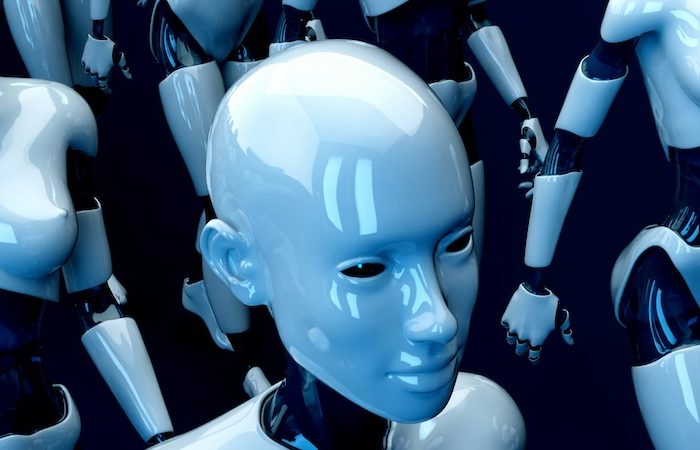Di: Dejanira Bada
“Il lato chiaro”
Cosa cerca l’essere umano? Un significato o un modo per sentirsi immortale? Di cosa ha bisogno un uomo? Di stare seduto a gambe incrociate in un ruscello gelido, tremando come un ossesso, cantando, invocando Dio per farlo entrare in sé? È di questo che abbiamo bisogno? E per fare cosa? Per capire qual è la verità? Chi ha la verità? Dove sta la verità? Perché abbiamo bisogno della verità? Perché abbiamo bisogno di Dio?
Kathmandu ha solo risvegliato altre domande, nessuna risposta. Qui è terra di molti e di nessuno, un crocevia di storie ed emozioni. Puoi meditare con i monaci durante la puja, restare in disparte come un fantasma ad ascoltare i loro mantra, le loro formule magiche che in te, umile osservatore che non capisci una parola, non sembrano altro che una specie di lavaggio del cervello. Puoi ascoltare i loro strumenti, i loro piatti, corni, tamburi, e avere la sensazione di sentire il cuore fuori dal petto che pulsa, che ti tiene in vita, che ti omaggia della sua presenza. Il cuore fuori dal corpo e il respiro sordo che striscia nelle vene.
Ma poi apri gli occhi e ti accorgi che i giovani monaci, invece, vorrebbero essere altrove, magari a giocare, e che si guardano in giro stufi. Sono irrequieti, la loro mente balla come una scimmia in gabbia. Sfogliano le preghiere poggiate sul tavolino e le contano, per capire quanto manca alla fine di quel tormento. Studiano che tutto è illusione, che la materia non esiste, ma poi piangono come gli altri, come le donne indù durante le cremazioni. Perché la vita sarà pure nient’altro che un ambire al ricongiungimento con l’Assoluto, ma di fronte al cadavere di un marito e di un padre lavato nell’affluente del Gange, tutto torna a essere così maledettamente terreno… e non c’è fede che tenga di fronte al lutto. È il dolore a sembrare più reale del corpo.
Il senso d’ingiustizia e d’incomprensione è deturpante e ci rende tutti vicini e simili. Altro che non-attaccamento, altro che impermanenza, altro che coproduzione condizionata. La gente vorrebbe solo restare e continuare ad amare e cogliere la bellezza.
Dare tutto e prendersi il meglio.
Perché se a volte è difficile trovare un motivo per svegliarsi la mattina, lo è anche trovarne uno per morire.
Il mal di montagna è come l’ubriachezza. Facile da capire e da superare per chi nella vita ha provato droghe e molto alcool.
Il primo giorno a Lhasa si ha la sensazione di essere in post sbornia.
La lentezza è una condizione naturale. I cinesi invece sono troppi e hanno infestato tutto con le loro inutili autostrade, inutili infrastrutture, inutili palazzi, inutili quartieri.
Le mani sono sempre secche e la testa pulsa. Il cervello sembra voler uscire e tornare a casa. I monasteri sono enormi, i buddha enormi.
I pellegrini si prostrano ovunque e pregano, pregano sempre, lasciano offerte. Chissà cosa chiedono, di cosa hanno così tanto bisogno.
Io non prego.
La spiritualità non è nei monasteri, nei templi o nelle chiese ma nei paesaggi.
Se cerchi qualcosa stai pur certo che non è fuori.
Il cielo azzurro sbatte contro la ruota del Dharma. Le nuvole candide danno un tocco di realtà. Nulla è mai limpido e chiaro, nulla è semplice e solo piacevole. Quell’immenso azzurro verrebbe a noia senza nuvole, dopo un po’ nessuno lo guarderebbe più, sarebbe soltanto un riflesso spento, come acqua ferma e stagnante. Guardare il cielo come quando ci si guarda allo specchio. Amarsi anche se non dovesse esistere l’anima.
Il cammino in salita a 4.000 metri è solo un cammino utile a diventare più forti. Il respiro si fa corto ma non per chi usa la respirazione yogica.
Bisogna aspettare, mettere un piede davanti all’altro, senza parlare, senza pensare, senza fretta. Arriva soltanto chi ha saputo pazientare. Piano e con fiducia.
Il tetto del mondo è ai miei piedi, la paura non mi potrà più fermare.
Schiavi delle abitudini, delle comodità, del buon cibo. Chi non ha mai patito non può cogliere molto del mondo.
La polvere dà e la polvere toglie.
Sta tutto lì, nel cercare di vivere senza avere troppa paura.
E si capiscono molte cose dopo una camminata a 4.700 metri per raggiungere il monastero di Drak Yerpa, abbarbicato sulla montagna con i suoi Buddha e le sue stanze dentro le caverne. Solo tu e la montagna, e quella fatica che si trasforma in forza, quella mancanza di fiato che dopo qualche passo si trasforma in leggerezza, come se si camminasse in assenza di gravità.
E lassù preghi, eccome se preghi; e lasci pure offerte, perché è dura, perché anche se non credi in niente, ringrazi di essere ancora vivo e di avercela fatta.
Il dolore, la sofferenza e la penitenza, acquisiscono maggior valore in questi luoghi. Diventa tutto una sfida con te stesso, e vincerla vuol dire tornare più forte, diverso.
È una vittoria contro la durezza del mondo.
L’uomo, per cercare il divino, è davvero disposto a tutto.
Il silenzio delle cappelle nelle caverne è qualcosa di spaventoso; e quell’odore d’incenso, quel fumo che si diffonde e toglie ancora più ossigeno; quel burro di yak che puzza, e che giace ai piedi delle fiammelle delle candele, e permette loro di ardere perpetue; quell’odore di cose mai lavate.
E i pellegrini, e i giochi e le corse dei bambini.
Non è un paese per deboli.
Le anime pulsano nei corpi dei giovani e degli anziani, puoi quasi vederle, quasi toccarle.
La mente si trova in quel vuoto all’interno del cuore.
I corpi sono forti e così gli spiriti.
Mancherà l’ossigeno ma si sorride di più.
L’aria è buona, si è più vicini al cielo: una scorciatoia per il paradiso.
In Tibet non esistono nemmeno i funerali. Qui i corpi vengono fatti a pezzi tra le rocce, sparpagliati sulle montagne, e dati in pasto agli uccelli. Niente cimiteri, un ritorno truce e reale alla terra.
Altri due passi e ci si può appendere alle stelle.
Le notti sembrano più corte, il riposo profondo.
I monaci suonano il gong e richiamano alla preghiera. I loro mantra invadono la valle, la loro meditazione penetra anche nei corpi dei più scettici.
Quel vuoto, quell’Assoluto, quel Dio, sembra volersi far cogliere e comprendere, ma la strada è ancora tanta.
Non basta l’altitudine, non bastano le preghiere e la contemplazione, né la disciplina. Spesso non basta una sola vita, e i monaci, forse, non sono altro che uomini spaventati, i più paurosi di tutti; timorosi della vita, del desiderio, dell’inferno, di tutto. La rinuncia alla vita è la scelta più facile per avere un cuore sereno. È la vita però che te lo fa battere, agitare, spezzare, fermare, e non l’ascetismo e il ritiro dove è richiesta pace, niente più che pace.
Io invece voglio la guerra nel cuore, voglio sentire, come la sorella di Milarepa.
Ma chi deve pregare per noi deve avere il cuore in pace, altrimenti non si possono trovare le forze per desiderare il bene di tutti.
“Il lato scuro”
L’ansia non è la benvenuta in paesi come questo. Il cuore batte più del normale e hai la sensazione di soffocare.
I bagni sono dei tagli nel cemento, delle fessure dove non passa mai acqua e dove puoi vedere gli escrementi di chi è passato prima di te.
Le mosche ci volano sopra, poi passano al ristorante accanto, dove il pranzo viene servito tra sporcizia e mozziconi buttati a terra.
La cenere vola ovunque. La carne di yak è nauseabonda e dura.
Inizio a sentire la stanchezza, non basta la spiritualità in questa terra troppo seria, dove le dune di sabbia scivolano nei laghi al cospetto di montagne verdi di 5.000 metri che qui sembrano niente più che colline.
La sabbia è bagnata, gli alberi possono nascere nei prati. Ce ne sono di più grandi, più veloci e in forma, altri più piccoli e fragili, come tutte le creature.
Le nuvole mangiano le montagne.
Guardo Qomulangma, la grande sorella sacra, madre dell’universo.
Il sole la illumina, le nuvole non la sfiorano nemmeno, vanno, vengono, la ricoprono, poi scompaiono.
La luna della notte detta il suo profilo imponente. La punta è ben chiara all’orizzonte, il suo profilo è quello di una bella donna, della Madonna, di Dio. Ma questo vale per noi occidentali, per molti tibetani il monte sarà pur sacro ma è anche il muro più alto del mondo che li divide dalla libertà.
Un tibetano mima il gesto dei fucili guardando in alto e poi mi spiega che si potrebbe andare lassù, tutti insieme, armati, passare il confine, scavalcare quel diavolo di Himalaya ed essere liberi.
Resterà un sogno, un racconto sul quale tutti abbiamo riso, ma per un attimo ci abbiamo creduto, lo abbiamo sperato.
Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo guardato il monte di fianco all’Everest, più basso, forse solo 7.000, e lo abbiamo immaginato possibile.
Poi l’amico dell’uomo che voleva fare la sparatoria ha guardato di nuovo Qomulangma, e sospirando ha detto: “questo è il mio paese”, un po’ arreso, un po’ fiero, un po’ sorridente.
Ci siamo fumati una sigaretta davanti a quello splendore che stupisce anche chi lo vede tutti i giorni e poi siamo andati a cena.
Perché qui, la neve sui picchi, ti ricorda l’ardore di un paese inginocchiato dal dittatore cinese.
Un uomo, a cena, ci ha raccontato di essere stato in carcere dieci anni per aver provato a combattere contro i cinesi negli anni ’90, o meglio, solo per aver osato resistere.
Non possono uscire, sono bloccati, reclusi, prigionieri nella loro stessa terra.
Uno ci ha messo sedici anni per ottenere il passaporto, e solo per andare in Nepal o in India, altrimenti niente visto.
Anche chi è tibetano e se n’è andato anni prima e vuole rientrare è trattato come un delinquente, e a volte bisogna aspettare anni anche per tornare.
La bellezza, la compassione, il Buddha stesso, non bastano a nascondere i divieti, i controlli, le ingiustizie, la propaganda, il totalitarismo, l’occupazione che si respira a ogni angolo di strada.
Paesaggi immensi che non fanno dimenticare la sensazione di essere controllati a vista.
Non si può parlare con chi si vuole, non si può parlare con i monaci, non si può viaggiare da soli, non si possono avere immagini del Dalai Lama, non si può sventolare la bandiera, si deve parlare cinese, obbedire.
I cinesi costruiscono immensi palazzi, ponti, autostrade, solo per far sentire il loro potere.
Devono sapere dove sei, con chi sei, dove vai, dove dormi, cosa fai, cosa vai a vedere, perché, quando, che strada fai, quando te ne vai.
Un ragazzo italiano, in aeroporto, ha detto che prima di partire alzava il pugno chiuso, dopo quello che ha visto non si definirà mai più un comunista.
Qui sembra non esserci più salvezza, altro che Buddha.
A breve il Tibet sarà definitivamente il luna park del cinese medio in cerca di “spiritualità”, ma non potranno mai avere la dignità dei tibetani, di coloro che stanno in alto.
Ma in fondo, neanche la Cina esiste, è solo un aggregato come tutto il resto, un insieme di corpi che di per sé non esistono.
Ai tibetani la capacità di elevarsi e illuminarsi, ai cinesi altre mille di queste vite.
La verità non è per tutti.
Tratto da Pangea
http://www.pangea.news/dejanira-bada-reportage-tra-nepal-e-tibet/